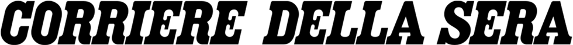Un uomo finito
di Pierantonio Pardi - Sabato 28 Gennaio 2023 ore 07:30

Ritratto di Giovanni Papini, un intellettuale molto problematico.
“ Io mi sento profondamente toscano. I veneti e i napoletani mi son estranei: non ci sto bene insieme: sento che non siamo della stessa razza. Non basta scrivere la stessa lingua ed essere governati dallo stesso codice per dire di aver la stessa patria. Anche fra i toscani mi sento spesso straniero e lontano. Ma quando dico Toscana intendo prima di tutto il paese toscano, i monti, i poggi, i fiumi, gli orizzonti di questo paese che dalle rosee torri delle Apuane finisce giù alla vasta e solitaria Maremma, tra le grandi cime dell’Appennino e il verde respiro del Tirreno (…) E poi intendo per Toscana i grandi toscani e il loro genio (…) dagli Etruschi che insegnarono la civiltà ai romani giù giù fino alla gagliardia di Dante, all’asciuttezza di Machiavelli, alla terribilità di Michelangelo, alla curiosità di Leonardo, alla penetrazione di Galileo.” (XLVI, pp. 303 – 305)
Chi scrive questa dichiarazione d’amore alla Toscana non è un “leghista ante litteram”, ma uno degli intellettuali più eclettici e contradditori del panorama culturale italiano del ‘900: Giovanni Papini.
Sì, proprio lui, l’uomo che insieme al suo amico Ardengo Soffici fu il responsabile dello smarrimento dei “Canti Orfici” di Dino Campana (anche se fu Soffici a perderli).
E il libro, da cui ho estratto la sequenza iniziale, si intitola “Un uomo finito”
Il romanzo, nell’arco di quarant’anni, ebbe più di venti edizioni e fu una specie di bibbia per molti giovani degli anni ’20 e ’30, così come lo “Jacopo Ortis lo fu per i giovani rivoluzionari del Risorgimento italiano. Il romanzo rappresenta un’importante testimonianza della cultura italiana degli anni ’20 che coincisero con l’avvento del fascismo e il tipo di intellettuale che emerge da queste pagine, come vedremo meglio in seguito, è una miscela di dannunzianesimo, irrazionalismo e ribellismo tout court.
Ma, prima di entrare nell’opera, vediamo un po’ più da vicino chi era Giovanni Papini.
Firenze, dove Papini nacque nel 1881 era il centro, fin dai primi anni del ‘900 di un vivace fermento intellettuale; una generazione di giovani vuol chiudere i conti con la cultura del decennio precedente. Le loro posizioni politiche sono disparate, ma sono tutti all’opposizione rispetto alla politica giolittiana. “L’Italia come oggi è non ci piace” scrive Giovanni Amendola nel 1910 su La Voce. L’opposizione al giolittismo coincide con la critica alla democrazia liberale e all’ideologia positivista e ricerca confusamente nuovi ideali, con sbocchi per lo più nazionalisti e autoritari.
Centro del nazionalismo italiano è la rivista Il Regno (1903 – 1906), diretta da Enrico Corradini a cui collaborava un giovanissimo Giovanni Papini insieme a Giovanni Prezzolini e saranno proprio loro, contemporaneamente, a fondare la rivista Leonardo (1903 – 1907) i cui temi sono l’imperialismo, l’esaltazione della guerra e l’appello alla borghesia affinché si ribelli con durezza al socialismo, insomma in nuce le premesse teoriche del fascismo.
Poi Prezzolini nel 1908 fonda La Voce con l’intento di reagire alle ubriacature ideologiche, invitando gli intellettuali all’analisi dei problemi concreti e raccoglie una serie eterogenea di collaboratori, eretici di tutte le chiese, nazionalisti dissidenti, cattolici modernisti, il filosofo liberale Giovanni Amendola e lo storico Gaetano Salvemini, socialista in dissenso con Turati. Essi promuovono inchieste e dibattiti sulla scuola e l’Università, la questione meridionale, la stampa …
Allo scoppio della guerra mondiale, tutti questi gruppi si troveranno schierati per l’intervento e, tra i sostenitori più accesi si distinguerà proprio Giovanni Papini con la sua nuova rivista Lacerba (1913 – 1915)
Scriverà: “ Ci voleva, alla fine, un caldo bagno di sangue nero dopo tanti umidicci e tepidumi di latte materno e di lacrime fraterne”
“Sul piano filosofico, l’ambiente fiorentino è il terreno di diffusione del pragmatismo di W. James e del vitalismo di Bergson; di queste idee vengono accentuati gli aspetti più irrazionalisti, all’insegna del superuomo nietzschiano, scoperto in quegli anni anche da D’Annunzio. Questi temi sono agitati confusamente da Papini e Prezzolini sul Leonardo (…)Più tardi Papini proclama la fine di ogni filosofia.”[1]
Invece Lacerba , la rivista che nasce come rivista letteraria d’avanguardia al grido di “ Freghiamoci della politica” finisce focosamente interventista e i suoi collaboratori Papini, Soffici e Palazzeschi aderiranno al futurismo.
Nella continua esibizione del Papini, fondatore e direttore, sono sin dall’inizio portati alle estreme conseguenze atteggiamenti già precedentemente delineatisi nella sua precedente collaborazione alla Voce , ma c’è, a tale riguardo, un articolo del 1912, particolarmente interessante. Il titolo è: Dacci oggi la nostra poesia quotidiana, dove sostanzialmente Papini riconosce un solo “valore” che è quello dell’arte fondato sulle rovine di tutte le leggi dell’umana convivenza e l’unica norma è quella del “sogno creatore” contro il “convenzionale regime della ragione”.
“ In questa ostentazione d’indifferentismo etico, la “poesia”, proposta come assoluta “libertà” del letterato, si ripresenta in una accezione del tutto evasiva ed edonistica. Quello dell’antidannunziano Papini ci appare una sorta di dannunzianismo rovesciato, becero e plebeo; l’ antiaccademia di non pochi fra i “lacerbiani” approderà del resto inevitabilmente alla peggiore accademia, quella del triviale, il loro ribellismo riuscirà infine nel più squallido conformismo, nell’accettazione e nell’esaltazione dei voleri del più forte.”[2]
Un uomo finito
Leggendo le prime pagine del romanzo di Papini si ha come la sensazione di un autore che, ormai vecchio, tiri un bilancio della sua vita; in realtà Papini scrisse Un uomo finito nel 1912 quando aveva superato da poco i trent’anni.
“Anche il titolo è ingannevole. Qui dentro c’è un uomo disposto a vender cara la sua pelle e che vuol finire più tardi che sia possibile. Se, piuttosto, qualcuno mi vorrà considerare finito, dice l’autore alla fine del libro, è perché volli incominciare troppe cose e non son più nulla perché volli essere tutto.[3]
Il libro si compone di 50 capitoli scanditi in sei parti (andante, appassionato, tempestoso, solenne, lentissimo, allegretto) che, come un partitura musicale fotografano i cambiamenti degli stati d’animo di Papini e delle diverse epoche.
Ma, soprattutto, quello che emerge fin dall’inizio di questa biografia intellettuale è il ritratto di un ragazzo, nato con una smisurata mania di grandezza ed una megalomania senza eguali.
Fin dalle prime pagine, nel primo capitolo intitolato Un mezzo ritratto Papini cerca subito di stupire il lettore: Io non son mai stato bambino. Non ho avuto fanciullezza scrive, descrivendo la sua solitudine e la sua diversità senza però capirne le cause; nel secondo capitolo Un centinaio di libri scrive: Mi salvò da codesta solitudine senza luce la smania di sapere e qui inizia il racconto del suo incontro con i libri, tra i quali, uno dei primi le Memorie di Garibaldi. Ecco come lo descrive : Ma uno dei momenti più divini della mia vita fu quando ebbi ogni diritto sulla biblioteca di casa. La libreria del babbo consisteva in una rustica cesta di truciolo con dentro poco più di cento volumi. Quella cesta era in una stanzina nascosta in fondo alla casa e che dava sui tetti – vera Alhambra delle mie fantasie – dove c’era di tutto: legni da bruciare, cenci smessi, trappole per i topi, gabbie da passerotti, un fucile da guardia nazionale e un’intignata camicia rossa garibaldina con la medaglia del ’60.
Il desiderio enciclopedico del sapere si traduce in uno studio “matto e disperato” sul tutto e sul niente e di questo Papini è consapevole. Quello che colpisce, infatti, in questo libro è l’estrema sincerità che finisce per renderci simpatico il suo autore. Lui non nega la sua megalomania. Sentite cosa scrive nel capitolo V (L’arco di trionfo): Io sono nato con la malattia della grandezza. Il mio primo ricordo è questo: avrò avuto forse nov’anni; stavo quasi sempre solo e leggevo spesso un libraccio di scuola pieno di grossolane figure e di scarabocchi violetti. Lì trovai un giorno la storia dell’incoronazione del Petrarca in Campdoglio e la lessi e rilessi. “Anch’io, anch’io” dicevo tra me, senza neppure sapere precisamente perché la corona fu messa in capo al grassoccio poeta.
Una confessione ingenua e quasi commovente…
L’anima di Papini, come trapela da queste pagine, è in un perenne stato di eccitazione intellettuale, ma d’altra parte c’è in lui anche la consapevolezza che non potrà mai acquisire per intero tutte le conoscenze, a cui seguirà la constatazione di dover vivere invece una vita provinciale, striminzita, mortificante, come descrive nel capitolo VI, Miseria: In quei tempi ero povero, decentemente ma atrocemente povero (…) ero borghesemente povero senza fame e senza freddo ma soffrivo. Non m’importava di andar vestito cogli spogli del babbo, consumati, lisi e infrittellati, con toppe ben messe dietro e in fondo ai calzoni, né di avere in tasca cappellacci sbertucciati, né di camminare con scarpe troppo strette, risolate e rimontate più volte.
La straordinaria modernità del romanzo è principalmente nello stile: la scrittura è roboante, convulsa, quasi violenta. Già l’esordio, di cui abbiamo già parlato, è una dichiarazione d’intenti. Certo, in molti punti la lettura è ostica, specialmente quando Papini si abbandona a disquisizioni filosofiche, morali o religiose. Però, il tratto distintivo di questo libro è la sincerità; Papini si mette a nudo, senza paura, anzi fregandosene del giudizio dei suoi simili.
Esemplare, a questo proposito, quello che scrive della sua opinione sull’amore (capitolo XXI): Se questo è un romanzo sarà un romanzo senza amore. Se questa è una storia sarà una storia senza donne. Sarà noiosa, monca, inverosimile (…) Non già, cara signora, che l’amore non abbia fatto parte della mia vita: tutt’altro. E dico amore in tutti i sensi: platonico e mandrillesco; spirituale e corporale; sentimentale e sensuale. E, dopo aver raccontato i suoi rapporti con le donne e, in particolare un rapporto finito male, conclude: Ed ora non parlerò più d’amore in questo racconto – neppure una volta. Ella può, cara signora, chiudere il libro e buttarlo via. E disprezzarmi profondamente – in piena coscienza.
E non manca in Papini l’autoironia, come quando nel cap. XXXV scrive: Tutta la mia vita è fondata su questa fede: ch’io sia un uomo di genio. Ma se invece sbagliassi, se fossi invece un di quei tanti orbi che prendono le reminiscenze per aspirazioni, i desideri per opere, e fossi, in una parola, un imbecille? Cosa ci sarebbe di strano? E’ forse la prima volta che un imbelle s’immagina di essere un eroe, che un letterato si crede un poeta e che un idiota si mette i panni del grand’uomo?
E qui mi fermo con gli esempi, altrimenti rischio di diventare didascalico, ma vi assicuro che ogni capitolo offre spunti divertenti e originali.
Vorrei concludere con questa riflessione che sintetizza in modo esemplare lo spirito del libro e riporta il giudizio di Boine:
Boine intravede nello stile di Papini lo stile dei grandi scrittori e poeti toscani, l’immediatezza e la solidità di un’espressione chiara e diretta, il tormento poetico di Michelangelo, la capacità di emozionare, commuovere, colpire la sensibilità e la spiritualità del lettore come soltanto i grandi della letteratura italiana sono riusciti a fare: Un uomo finito è un libro che non realizza un progetto artistico o morale. Papini attraverso la narrazione della sua vita intellettuale e spirituale esprime un bisogno dell’anima e del genio creativo: Un uomo finito non raggiunge un obiettivo ma trova in sé la ragione del suo essere, è l’urlo di dolore di un artista che sta per soffocare nel mondo della filosofia classica e dell’assolutismo e che ha scelto di essere un uomo moderno, un letterato che si serve della parola per contestare, abbattere, cambiare il mondo: «Io sono, — scrive Papini — per dir tutto in due parole, un poeta e un distruttore, un fantastico e uno scettico, un lirico e un cinico (…) continua Papini — son rimasto, insomma, l’uomo che non accetta il mondo e in questo mio atteggiamento ostinato consiste l’unità e la concordia delle mie anime opposte. Io non voglio accettare il mondo com’è e perciò tento di rifarlo colla fantasia o di mutarlo colla distruzione. Lo ricostruisco coll’arte o tento di capovolgerlo colla teoria. Sono due sforzi diversi ma concordi e convergenti. n[4]
Ecco, questo è stato Giovanni Papini.
Di più su questi argomenti:
[1] G.Armellini, A.Colombo, La letteratura italiana (zanichelli), pg. 498
[2] Gianni, Balestrieri, Pasquali, Antologia della letteratura italiana ed D’Anna, 1983, pg 668
[3] Dalla “Redazione virtuale”
[4] Vincenzo Regina, Giovanni Papini e la modernità. L’anima di “Un uomo finito” di Boine, dalla “Voce” 1913.
Pierantonio Pardi