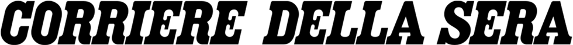Fumo
di Marco Celati - Giovedì 22 Novembre 2018 ore 07:35

Ci sono notti che l’aria sa di fumo. Forse sono i gas di scarico delle auto che tutto il giorno attraversano la città. Oppure è la discarica, alla periferia, dove brucia qualcosa. O è il monte, in fiamme per la follia criminale di piromani incendiari. A me invece piace pensare che sia un ricordo di quando alla luna accendevano i falò. Sulle colline, nelle campagne per propiziare i raccolti. Perché non è un odore cattivo, di quelli che prendono alla gola. È un odore buono come di legna sul fuoco o di brace, di pane abbrustolito, di antica trattoria che si respira la sera per le straducole di un paese toscano capitato per caso. Sa come di incenso delle chiese nelle funzioni del vespro. Ti affacci al terrazzo e lo senti questo odore familiare che fa un po’ malinconia. Guardi le finestre illuminate dei palazzi e ti viene di cercare la luna ed è una luna rossae ricordare una cena con qualche amico e dopo cantare, pensando al futuro che sarebbe stato e la vita da fare. Che per qualcuno non fu nemmeno molta, per altri perfino inutile. La vita che c’era e l’amore. E il fumo delle candele che si spengevano a poco a poco. Che sarebbe il nostro tempo senza nostalgia?
In questa notte i veri scrittori, quelli che hanno qualcosa da raccontare, vegliano e scrivono le loro storie vere o i loro gialli inventati. Mi chiedo se anche dire di questo fumo che sento sia scrivere o se non sia il caso di dare la buonanotte e fare punto qui. Potrei raccontare un viaggio in Senegal e tante cose viste o fatte, ma si può raccontare la vita? Perché? Per insegnamento, per tramandarla. Per rifletterci su o piuttosto per riflettere noi stessi, come narcisi? Forse si scrivono solo i sogni o le mancanze. E vale il vecchio detto: o si vive o si scrive. Che però suona troppo roboante come fosse: o Roma o morte. Oppure fatalista: o la va o la spacca. Uso spesso la congiunzione “o” in senso aggiuntivo o disgiuntivo. “O” mi piace, è rotondo, pieno, sta per “oppure” o per “ovvero”, “ossia”. E si può utilizzare a caso, conservandone l’ambiguità. Si addice a un ragionamento circolare. Forse però sarebbe meglio usare la “e” per dire: “si vive e si scrive” e assolvere noi stessi da riservatezze, timidezze o eccesso di riflessioni. E andare avanti.
È che ho approntato un tavolinetto, finto antico, addossato alla parete sotto la finestra che guarda la scuola. Sotto il pad trasparente ci sono immagini dell’isola di Gorée, la Maison des Esclaves. E poi il passaggio degli studenti, la luce che filtra dalle tende, tutto ciò dovrebbe essere evocativo. Eppure il tavolo resta lì a prendere la polvere. Preferisco scrivere in penombra, nel silenzio, sul tavolo di cucina con la tovaglia di plastica color crema, istoriata da rose, tazzine da tè, finte trine e calligrafie, comprata dal cinese. Mi pare più familiare, alla mano, alla mia portata. A volte lascio accesa la radio, così ascolto in sottofondo voci e canzonette che mi distraggono dagli assalti di patetico romanticismo. Poi se qualche logorroico annunciatore rompe troppo i coglioni e perdo i pensieri, mi alzo e la spengo.
A volte penso che l’ispirazione non venga dalla testa e dal cuore, ma dalla stanza dove sei, dal tavolo su cui siedi per scrivere, dallo schermo luminescente del tablet, dalla tastiera che sbaglio a digitare e le parole escono tutte insieme litigando con il suggeritore e il correttore automatico, legate tra loro in fila, in corsa dietro a un pensiero. Ma forse scrivere dello scrivere vuol dire non sapere più cosa scrivere. Gli scrittori veri non mi calcolerebbero neanche per commiserazione. I moralisti disapproverebbero. Libero, uno che conosco, Libero Venturi, che anche lui si diletta a scarabocchiare qualcosa, pure lui in un blog, mi dice Celati -chiama tutti per cognome- è inutile questo tuo indolente solipsismo piccolo borghese, non se ne può più! Lui è Libero di nome e di fatto. Anzi, sostiene che “nomina sunt consequentia rerum”, usa il latinorm e così io mi chiamerei Celati perché mi celo, mi nascondo. E se ne esce con considerazioni critiche sul mondo o su ciò che gli passa per la testa, a volte brillanti, a volte francamente noiose, quasi sempre troppo lunghe, ma, convinto com’è, non se ne rende conto e non se lo vuole nemmeno sentir dire. Dice che non gli importa, che bisogna studiare, che un giorno la gente capirà. Ma lui non dice gente, perché la gente gli va stretta. A me invece sta larga, questa è la differenza fra noi. Mi fa perdere un sacco di tempo con le sue elucubrazioni, con il suo impegno d’altri tempi che mi verrebbe voglia di non considerarlo più, di farne a meno. Ma poi mi dispiace, il suo fastidio ormai fa parte di me.
Se esco e parlo con qualcuno, capisco che alle persone bisogna dargli ragione perché continuino a darci torto. Ma poi questa esposizione pubblica mi crea disagio e disturbi fisici, così devo tornare a chiudermi in casa e starmene un po’ solo. E poi mi fa tristezza, come una fiera di paese quando siamo grandi. Soffro di agorafobia. Ho contratto una sorta di autismo sociale che nel corso degli anni si fa sempre più acuto e diffuso, insieme agli acciacchi della vecchiaia. E poi per parlare bisogna avere un bell’aspetto, una bella dentatura per sorridere in pubblico, tutte cose di cui non dispongo più da tempo. E amore da ricevere e dare. A questo punto, per non trascendere, occorrerebbe una canzonetta, una qualsiasi di quelle che escono dal tablet o dalla radio. Radio Cuore, che è tutto un programma. “Volevo te” di Giusy Ferreri va benissimo: “e passano i giorni,/ partenze senza ritorni, / graffiano i muri, le mani / e noi che siamo lontani”.
La lontananza dove ogni canto, ogni cosa muore a poco a poco, è un bel concetto. Siamo figure nella lontananza che è come una nebbia del tempo. Come un fumo che si leva e tutto avvolge. E anche noi siamo profili, antiche ombre, stagliate su un orizzonte dove si confondono paesaggi, case, alberi, presenze reali, sogni e perfino memorie di coloro che non sono più tra noi e tornano via via a farsi ricordare. Una luna rossa. Ricordi di ciò che siamo stati o non siamo stati mai, un orizzonte che sfuma e si allontana. Sfugge come la giovinezza e la vita. “La lontananza sai è come il vento”, cantava Modugno. Come il vento che si leva o il fumo che si sente questa notte.
Marco Celati
Pontedera, 16 Ottobre 2018
_______________________
“Vaco distrattamente abbandunato / ll'uocchie sott''o cappiello annascunnute / mane 'int''a sacca e bávero aizato / vaco siscanno ê stelle ca só' asciute./ E 'a luna rossa mme parla 'e te / io lle domando si aspiette a me / e mme risponne: Si 'o vvuó' sapé / ccá nun ce sta nisciuna”. Luna Rossa la cantava il Mago al Bar La Posta. Foto, dipinto e rielaborazione grafica sono dell’autore.
Marco Celati