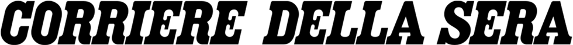Cristobal
di Marco Celati - Lunedì 20 Settembre 2021 ore 07:30

Nueve meses de invierno y tres de infierno! Risponde al vero l’antico detto castigliano: nove mesi d’inverno e tre d’inferno. Ma che storia è mai questa? Cosa ci faccio a Valladolid? Qui, come dice il proverbio, il clima è tipico delle terre interne: rigido, basse temperature come d’inverno ed estati caldissime e afose. Sono finito nell’attuale capitale dell’impero, in mezzo alla Spagna, lontano dal mare Oceano che mitiga il tempo e offre all’orizzonte l’infinito. Io che sono sempre stato più vicino alle coste, ai porti, agli imbarcaderi da cui le navi lasciano le rive. Che ho navigato per mari e scoperto continenti e ora mi trovo circoscritto dalla terra e dalla vita. Quaggiù solo fiumi straripanti e umidità che col freddo ti rimane addosso e quando fa caldo ti leva il respiro. Sono distante anche dalle corti dove i regnanti di Castiglia usavano ricevermi. La Regina Isabella di Castiglia e León, “la Cattolica”, la mia protettrice, è morta ormai. Resta il consorte, il Re Ferdinando II d’Aragona. I miei fratelli Bartolomeo e Giacomo, detto Diego, che mi hanno seguito per mare, non ci sono. I miei familiari morti o dispersi, la morte toglie, la vita divide.
Sono rimasto solo. Mia moglie Filipa è morta da tempo. Filipa Moniz Perestrello, una nobile portoghese. C’eravamo sposati che lei aveva 25 anni e io 29, era il 1480, un anno dopo è nato Diego e nell’85 lei è morta. Aveva 30 anni. Mio figlio Diego ha seguito le mie orme nelle nuove terre oltremare, ora è a corte e gli ho chiesto di farmi ricevere dal Re, nonostante senta che tutto intorno mi è divenuto ostile. Che disperazione cadere in disgrazia! Penso spesso a Beatriz, Beatriz Enríquez de Arana, ci siamo amati dopo la morte di Filipa, lei ventenne, bella, figlia di contadini, viticultori e mercanti. Orfana. Di anni allora ne avevo 35, mi pare. Non ci siamo mai sposati, lei era di basso lignaggio e io sono divenuto addirittura Ammiraglio del Mar Oceano, Viceré e Governatore delle Indie, Amministratore delle colonie nell’isola di Hispaniola a Santo Domingo. Eppure anch’io venivo da una famiglia di mercanti italiani, da Genova, dove sono nato nel 1451 o dall’entroterra ligure o piemontese. E ora che non ho più titoli, me li hanno tolti tutti, non ho più nemmeno una donna al mio fianco. Ci sono giorni in cui bramo un’ombra gentile che mi segua. Abbiamo avuto anche un figlio, Fernando. A tredici anni l’ho portato con me nel quarto ed ultimo viaggio nelle colonie. É uno scrittore, un matematico e un geografo. Vuole scrivere un romanzo sulla mia vita.
Ho avuto anche un’altra Beatriz, de Bobadilla y Ulloa, nipote della marchesa Moya e vedova del governatore di La Gomera. Ma fu un amore così, così, qualcuno dice di interesse. Beatrice viene dal verbo beare. Invece, durante i miei viaggi, Beatriz Enríquez ha allevato nostro figlio Fernando, insieme a Diego, il primo figlio legittimo. Li ha educati bene, devo riconoscerlo. Perfino la Regina Isabella l’ha lodata per questo. Ormai la mia vita non veleggia più in mare aperto e con la morte, come tutti, devo fare i conti, così lascerò scritto che quando non ci sarò più, mio figlio Diego si prenda cura di Beatriz e dei suoi eredi. A lei ho destinato il denaro ricevuto per aver avvistato la terra nel primo viaggio. Sarebbe forse aspettato a Rodrigo. Rodrigo de Triana, era un moriscos, un islamico convertito, il marinaio che sulla coffa della Pinta gridò: «Terra!!!». Erano le due di notte del 12 ottobre 1492. Me lo ricordo bene. Un venerdì. Ma prima, durante la notte, mentre guardavo la luna sperando mi portasse follia, avevo intravisto un luccicare lontano, come una piccola candela che si levava e si agitava, e così mi attribuii il premio.
La mattina sbarcammo, trovando un varco tra la barriera corallina. Battezzai quell’isola con il nome di San Salvador, perché fu la nostra salvezza. Avevamo avuto diverse vicissitudini alla partenza, finché gli Alisei, propizi, soffiando da nord-est a sud-ovest, gonfiarono le vele. Ma dopo giorni di navigazione l’equipaggio era stanco e sfiduciato. Vi fu un principio di ammutinamento. Non era tanto il tempo, era l’ignoto a spaventarci, tutti i giorni sotto cieli e soli e, ai lati delle navi, nuvoli bassi, galleggianti nell’aria, come navigare in un fiume infinito. E sempre, sempre, sempre questo Oceano insondato, oltre noi, oltre il mondo conosciuto. Eravamo salpati due mesi prima, alle sei del mattino del 3 agosto da Palos de la Frontera. L’intenzione era tracciare la strada più breve attraverso il mare per raggiungere l’India. E ora quella rotta e il nuovo mondo erano nostri. Mi inorgoglisco ancora a ripensarci, ora che sono confinato tra queste terre ferme e rimpiango la spuma che lo scafo fendeva e la scia che lasciava e mi sembra di sentire ancora il vento che soffia e ci porta al largo verso l’orizzonte, dove il sole tramonta. Ora che soffro di mal di terra e invecchio e muoio. Quattro viaggi ho fatto oltreoceano, ho fatto cose incredibili e alcune innominabili. Non di tutto nella vita c’è da essere fieri. Ho conosciuto e praticato cortesia e crudeltà. Mi hanno accusato di tirannia, brutalità e cattiva amministrazione. Perfino il carcere ho provato e la successiva riabilitazione. Di me dicevano che ero loquace, un affabulatore appassionante e convincente e che, come uomo di mare, non ero “docto”, ma “bien entendido”. Ne ho subiti di torti, nel “Memorial des Agravios” li ho elencati tutti, ma a corte non li riconoscono, né comprendono più l’importanza delle mie scoperte.
Il Re finalmente, dietro l’insistenza di mio figlio Diego, mi ha ricevuto. Mi hanno offerto Carrión de los Condes, un piccolo comune che langue delle antiche memorie del Cid. Ho rifiutato e mi sono ritirato a Valladolid per quel poco che mi resta ancora da vivere. Tanto vale che mi sotterrino qui. Volevo ricordare a Re e cortigiani, con tutto rispetto e gratitudine per la corona e per la fede che mi ha sempre guidato, che la Niña, la Pinta e la Santa Maria erano caravelle, velieri, nemmeno navi. Bisogna avere tre alberi e tutte vele quadre per essere navi. Della Pinta si ruppe subito il timone, alla Niña facemmo modificare la vela, da latina a quadra, necessaria per la navigazione oceanica. Dopo la partenza, ci volle lo scalo di un mese a La Gomera. Fu lì che ritrovai Beatriz de Bobadilla… Sette anni mi avevano fatto aspettare, tanto è durata la mia battaglia e quanti rifiuti! In Portogallo, in Spagna, avevo perfino intenzione di rivolgermi a francesi ed inglesi. Dopo anni di soggiorno nel regno di Castiglia, mi sono ritrovato a vendere libri e disegnare mappe per campare. A Lisbona invece avevo studiato carte e testi, interrogato naufraghi. Sono andato per mare fin da giovane e avevo veleggiato io stesso verso quelle rotte. Sapevamo, lo sapevano già i greci e gli uomini colti del nostro tempo, che la terra è una sfera. Solo gli sciocchi possono pensare che sia piatta. In futuro, quando i nostri discendenti avranno altri strumenti, nuova scienza e progresso non ci sarà più chi né dubiterà. Quindi, come sosteneva già nel 1474 Paolo Toscanelli, il fisico fiorentino, era percorribile una rotta verso ovest per raggiungere l’India, il Catai e il Cipango di cui avevo letto nel Milione di Marco Polo.
Alla fine per l’armamento della flotta i Re spagnoli stanziarono solo 2 milioni di maravedí. Ai vostri tempi corrisponderebbero ad una somma variabile, a seconda delle stime, tra 20 e 60 mila euro. Una cifra modesta per una spedizione oltre i confini stessi della storia. Esplorare è guardare al futuro, al di là dei limiti della conoscenza. Forse bisognerebbe accontentarsi della terra, ma i navigatori hanno nostalgia del futuro e si svegliano ogni giorno con la bocca che sa di sale e ogni giorno affrontano il mal di mare che è la loro cura contro il mal di terra che li affligge da sempre. Perché negli occhi hanno l’orizzonte e nella vita non si sa. Forse il mare aperto e la deriva di sé.
E se non fosse stato per Pinzón, i fratelli Pinzón, armatori di Palos – Martín Alonso, capitano della Pinta, il mio comandante in seconda,Yáñez e Francisco a capo della Niña – chissà come sarebbe andata! Io guidavo la spedizione e capitanavo la Santa Maria, la nave ammiraglia, una caracca in realtà. Ne era proprietario Juan de la Cosa, un cantabrico, che era il pilota della flotta. Martín Alonso, l’esecutore pratico della navigazione, fu lui a riparare il timone della Pinta. Per lui io ero un temerario avventato, incurante dei bassifondi rocciosi, che navigava senza una rotta precisa. Me lo disse quando la Santa Maria si incagliò: andò in secca di prua. Ci arenammo sopra un banco corallino a poca distanza dalla costa dell’isola Hispaniola. Fu verso la mezzanotte di Natale. La nave fu abbandonata. E anche 39 marinai nel forte che costruimmo con i relitti della nave e chiamammo “La Navidad”. Li lasciammo al loro destino e ripartimmo con la Niña, la più piccola della flotta. Anche Martín Alonso con la Pinta ci aveva abbandonati senza autorizzazione, in cerca di oro e fortuna nell’isola di Babeque. Due mesi dopo ci riunimmo e facemmo rotta sulla via del ritorno oltre gli Alisei, a settentrione, all’altezza del Portogallo. L’uragano che infuriava sull’Atlantico, c’investì per due giorni e due notti, squassando le caravelle. Le onde altissime separarono le imbarcazioni. La Pinta sparì dalla vista. A bordo della Niña, sbalzata dai flutti, tememmo la morte e facemmo voti a Dio e alla Madonna di aver salva la vita. Fortunosamente riuscii ad approdare alle Azzorre, dove, male accolti dai portoghesi, facemmo scalo. E da qui, ripartiti con la nave malconcia, riparai nel porto di Lisbona che invece il re del Portogallo, Giovanni II, nonostante avesse rifiutato di finanziare l’impresa, cortesemente concesse per il ristoro della Niña. Era il 6 marzo del 1493. E finalmente, il 15 marzo, sbarcammo a Palos dove tutto aveva avuto inizio, da dove eravamo partiti per il nostro incredibile viaggio. Martín Pinzón, scampato al fortunale, aveva raggiunto per primo la Spagna a Baiona e, su ordine della Regina, fece vela per Palos con la sconquassata Pinta per riunirsi a noi. Arrivò poche ore dopo. Stava male e in breve tempo morì. Martín, Martín, indisciplinato compagno di avventure, io sarò stato anche un temerario, in compenso tu avresti dovuto temere i tuoi accoppiamenti, vecchio puttaniere! Sarà stato questo a procurarti il misterioso male che ti portò alla morte, una volta rientrato in patria.
A Siviglia, Cordova e Barcellona furono giorni di festa. Giornate memorabili. Fui accolto con onori trionfali dai sovrani. Avevamo portato un po’ di oro, tabacco, alcuni pappagalli in dono e dieci indiani Taino, i nativi gentili che ci avevano accolto a San Salvador, che loro chiamavano Guanahanì, ridotti in schiavitù. Le isole dell’India, oltre il Gange, disponevano dunque di simili tesori e potenzialità. La Regina e il Re mi sollecitarono una seconda spedizione. In quell’occasione portammo con noi 20 cavalli e 5 giumente, animali sconosciuti ai nativi e da loro temuti, introducendoli in quei territori. Di spedizioni ne seguirono una terza e una quarta. Tutte di minor fortuna. Piene di insidie e tragiche evenienze. Tradimenti e brutalità. Nell’ultimo viaggio, mi feci accompagnare da mio fratello Bernardo e da Fernando, il mio secondo figlio; ero invecchiato tanto da non poter tenere il comando della nave. Nel 1503 arrivammo alle isole che chiamai Las Tortugas, tante erano le tartarughe marine presenti nelle acque. Che meraviglia! Però le teredini, terribili parassiti che divorano il legno, infestarono gli scafi, una nave cedette e dovemmo abbandonarla in un’insenatura. Con le altre, che imbarcavano acqua, riparammo sulla costa della Giamaica. Gli indigeni che ci fornivano cibo, stavano per ribellarsi, ma, grazie alle mie nozioni astronomiche, previdi un’eclissi lunare e dissi ai nativi che il mio potente Dio era in collera con loro e avrebbe oscurato il cielo e arrossato la luna. Ciò che puntualmente avvenne, così loro, spaventati, tornarono a sottomettersi. Quasi certamente salvammo la pelle, ma non mi sento particolarmente fiero di aver usato la conoscenza per atterrire e accrescere superstizioni. L’anno dopo, il 1504, rientrammo in Spagna pagando di tasca nostra il viaggio di ritorno. Non mi sento esente da colpe. Chi lo è? Sono stato un conquistador e uno schiavista? Per la verità ero partito per scoprire una rotta, non un nuovo continente: una rotta occidentale per raggiungere l’Estremo Oriente attraverso il mare. Questo almeno era nelle mie intenzioni. La schiavitù, è vero, esisteva e, se per questo, anche l’Inquisizione spagnola, il Sacro Uffizio e gli autodafé.
Seguirono comunque per me rovina e discredito presso la corte di Castiglia. Pensavo alla conquista dell’Eden, come a quella di Gerusalemme, alla conversione del mondo alla fede cristiana, un millennio di pace prima dell’Apocalisse, preludio della fine del mondo. Lo scrissi nel “Libro delle Profezie”. Adesso non sono più certo. Un dubbio mi è venuto dopo il terzo viaggio: che non siano le Indie, il nuevo mundo che ho scoperto e in parte esplorato, che si tratti di un nuovo continente, magari essendo la Terra una sfera di più vaste dimensioni? E di fronte all’ingratitudine degli uomini, la mia fede resta, ma si è fatta più stanca. Come sono stanco io. Chissà cosa resterà di tanto ardore, della terribile e mirabile avventura della vita, delle nostre scoperte e speranze. Che ne sarà? Chissà se mi ricorderanno nella gloria, nel bene o nel male o un pietoso oblio si stenderà su tutto ciò. C’è chi dice che è preferibile restare invisibili all’ombra della storia, ma solo ciò che viene ricordato vive. È che sono vecchio ormai. E solo. È così che mi sento. L’età media degli uomini è intorno a 50 anni e io li ho superati da un lustro. In fondo sono stato fortunato. Ho vissuto tanto, troppo e ne ho viste di cose. È da tempo che quando urino sento male, troppo sale rimasto nel corpo dal mare e dall’aria salmastra. Le ginocchia sono gonfie e deboli, non abituate alla terra ferma, senza il morbido rollio della nave e mi bruciano questi occhi, che hanno contenuto l’orizzonte, arrossati da troppi tramonti. La vita, nonostante la sua finitezza, appare inconcludente e indecifrabile: come lasciare una parentesi aperta o un asterisco senza spiegazione. Non c’è solo guadagnarsi il pane per non morire e fare figli per non finire: noi siamo meno di ciò che si presume, ma più di ciò che appare o si racconta.
Io, Cristoforo Colombo o Cristóbal Colón, come mi chiamai nel corso della vita, morirò a Valladolid il 20 maggio 1506, vigilia dell’Ascensione, a causa di un attacco di cuore. Il mio cuore, gonfio di onde, di entusiasmi e di pene, cessò di battere. I sintomi descritti nei miei diari erano quelli della sindrome di Reiter. Un morbo studiato in seguito dal medico nazista Hans Reiter. Avevo 55 anni.
Se i miei viaggi da vivo furono avventurosi, non lo furono da meno quelli da morto. Nel 1506 sono stato sepolto nel Convento di Valladolid. Dopo un periodo di oblio, nel 1518 le mie spoglie mortali furono inumate presso la Certosa di Santa Maria de Las Cuevas a Siviglia. Dopo di che, per vicissitudini varie e misteriose, sembra che resti di me siano stati ritrovati nel 1537 e custoditi nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Incarnazione, a Santo Domingo e nel 1795 nella Cattedrale dell’Avana, oltreoceano. Dal 1902 invece risulta che i miei resti giacciano di nuovo nella Cattedrale di Siviglia. Ma non si sa se quelle spoglie siano le mie o quelle di un mio congiunto ed è ancora aperto dopo secoli un contenzioso circa il DNA dei vari resti. Insomma c’è una disputa sulla mia vera tomba che alla fine nessuno sembra voglia risolvere davvero, per ragioni dovute all’interesse della memoria.
Non meno inestricabile è il nodo relativo alla mia successione, nonché alla causa per la discendenza e l’eredità dei beni che Diego, mio figlio, in buona parte aveva riconquistato. C’era in ballo un maggiorasco accordatomi dai sovrani di Castiglia e Aragona che doveva essere ereditato da un discendente maschio o dai parenti e, inoltre, il titolo di marchese della Giamaica, il Ducato di Veragua più una rendita fissa. Gli eredi maschi si sono estinti e alla fine, dopo una sorta di pronunciamento giurato, quel tanto o quel poco che restava di titoli e sostanze fu assegnato anche ai discendenti in linea femminile. Ma rimase un’incertezza tra i rami dei Colombo di Genova e quelli del Castello di Cuccaro a Monferrato, compreso allora nella Repubblica genovese. Poi della gran parte delle cose umane con il tempo si perdono le tracce.
Tutti mi hanno eretto statue: a Genova, a Lisbona, a Barcellona, a Madrid e altrove. Perfino a Rapallo. In genere mi raffigurano su alte colonne, in piedi, che addito l’Oceano, il mare, le mie patrie vere. Alcune statue oggi le tirano giù: sostengono fossi uno schiavista. Si fanno sempre male i conti con la storia. Non è stato facile nemmeno per me. Accidenti alla storia, agli storici e tutte le storie! Anche se è solo nella storia che posso essere compreso. Mi hanno immortalato in numerosi dipinti: opere postume, dedotte da descrizioni di contemporanei o del tutto fantasiose. All’esposizione mondiale in mio nome del 1893 sono stati esposti 71 miei ritratti. Ma nessuno mi raffigura di preciso, sa che sembianti avessi. Non certo il ritratto eseguito da Sebastiano del Piombo che mi dipinge pasciuto e austero con capelli color rame, né quello più noto di Rodolfo Ghirlandaio che mi raffigura con una faccia paffuta e rotonda. Vi posso dire che il più veritiero forse è quello che compare nella Madonna dei Navigatori di Alejo Fernández dove appaio in un’ampia veste dorata alla destra della Vergine, con il volto tirato, un po’ calvo, con capelli biondi e riccioluti. Avevo carnato chiaro, leggermente lentigginoso e chiari anche gli occhi: azzurri o grigi come il mare che cambia colore a seconda del cielo e del tempo. Ero alto per allora: più di un metro ottanta. Qualche rara testimonianza lo riporta.
Anche su nascita e nazionalità vi è poi da ridire. Onestamente Genova è quella da attribuirmi. Ma dicono anche Savona o altre località della Liguria o dell’interno, sempre nella Repubblica di Genova. Mi contendono anche la Spagna e il Portogallo. Perfino la Polonia. E forse i miei genitori erano ebrei sefarditi o marranos, convertiti, in fuga dalla Spagna e approdati nel genovese. Insomma quante incertezze aleggiano sul primo vero scopritore del nuevo mundo, che lo volesse o meno! Per essere uno che ha fatto la storia, speravo qualcosa di meglio, un riconoscimento più preciso dei miei meriti, oltre che dei miei molti errori.
E invece resto quello che ha scoperto per sbaglio questo nuovo mondo. Che meno male c’era un nuovo continente fra l’Europa e l’Asia e le Indie perché sennò saremmo stati inghiottiti dall’Oceano con le nostre piccole caravelle o avremmo dovuto tornare indietro senza scoprire alcunché. E non solo c’era un altro continente, ma perfino un altro Oceano che Magellano, il grande navigatore portoghese, attraversando lo stretto impossibile che da allora porta il suo nome, scoprì e chiamò Pacifico, perché lo trovò calmo, più calmo dell’Atlantico furioso. Andò al di là della Patagonia, dove il più prudente e accorto Vespucci si era fermato. Ma anche Magellano seguiva il mio errore: cercava la rotta via mare per raggiungere le Indie, non tanto continenti ed oceani. Così si potevano estendere i valori della cristianità e dei re che la incarnavano, aggirare il mondo islamico, riprendere Gerusalemme, instaurare un mondo di pace e poi venisse pure l’Apocalisse e la fine del mondo. Magellano fu il primo a circumnavigare il globo e quando era ormai quasi al termine della sua impresa, si fece uccidere da una rivolta nelle Filippine, sceso a terra per cercare di domarla. Noi se valiamo qualcosa è sulle tolde delle nostre navi, sulle acque aperte degli oceani, sulla nuda e dura terra siamo destinati a soccombere. Il mare è per navigare, la terra per essere sotterrati. Il suo marinaio Pigafetta, rientrato in patria, ne raccontò le gesta.
Abbiamo fatto il nostro tempo, dato nuovo avvio alla storia. Abbiamo navigato nello spartiacque tra il vecchio e il nuovo. Ma io, pur spinto dalla volontà di scoprire nuovi orizzonti, sono stato un uomo del basso Medioevo. Amerigo Vespucci, nobile fiorentino, divenuto castigliano anche lui, al servizio di Spagna e Portogallo, era più giovane di età e sopratutto di idee. Probabilmente in lui cresceva qualcosa, anche solo un germe, del futuro Rinascimento. Era colto, cosmografo e astronomo, scriveva, pubblicava sfruttando l’invenzione della stampa e comunicava con il mondo di quell’epoca, di quella società dominante, inquieta e affluente. Ci conoscemmo a Siviglia nel 1489. Poi io feci la mia grande impresa. Seppur per caso, ma non del tutto, ho scoperto il nuovo mondo, anche se credevo fosse ancora il vecchio, e i suoi nuovi popoli, che forse non avevano così voglia di essere scoperti. Per colpa mia si chiamarono indiani. Ma Vespucci fu il primo a rendersi conto e a dichiararlo apertamente che quello in cui mi ero imbattuto non erano le Indie e nemmeno genericamente un nuovo mondo, ma più precisamente un nuovo continente. Che così porta il suo nome, mica il mio: America. E l’America, nel bene e nel male, ha cambiato il mondo e la storia.
E a me che resta alla fine? Di tanta fatica, di tanto viaggiare ed esplorare? Una gloria tanto imperitura quanto casuale, la Columbia e, in qualche modo, Washington D.C che, pochi lo sanno, sta per District of Columbia.E infine l’ineffabile invenzione dell’uovo di Colombo che è più una presa in giro. Dicono che al ritorno dalle presunte Indie nel 1943, a cena con il Cardinal Mendoza alcuni gentiluomini spagnoli avrebbero asserito che in fondo la mia impresa era stata facile e chiunque avrebbe potuto compierla. Allora sembra che io li abbia sfidati a far stare dritto un uovo sul tavolo. Tentarono, ma nessuno ovviamente ci riuscì, dopo di che io praticai una piccola ammaccatura all’estremità dell’uovo che così stava in piedi. Tutti allora dissero che in quel modo anche loro avrebbero potuto farlo e io risposi secco che loro avrebbero potuto, ma solo io l’avevo fatto. Per la verità l’aneddoto fu attribuito anche al Brunelleschi che l’avrebbe mostrato agli scettici che dubitavano della sua capacità di elevare la cupola del Duomo di Firenze. Peccato che sia falso.
Meritavamo miglior fortuna. Ma se mancò la fortuna, non mancò certo il coraggio. A tutti in fondo manca qualcosa: ai poeti sempre un verso e ai poveracci tre soldi per fare una lira. Per non parlare della felicità e della salute. Alla fine la vita per tutti è sempre un’incompiuta. Il corpo dell’impavido esploratore Ferdinando Magellano, colui che per primo si accinse all'impresa più grande in assoluto della storia della navigazione, non fu mai restituito, non se n’è mai conosciuta la sorte: un monumento sepolcrale in sua memoria è posto sulla spiaggia di Mactan, dove si presume sia stato ucciso.
Il nostro cammino per nuove conquiste in mare, in terra e in cielo non si è arrestato. Magari occorrerebbe conseguire giustizia e rispetto della natura e non volontà di dominio, ma è dell’uomo vivere e progredire. Però bisogna saperlo come vanno a finire queste cose. Anche il mitico navigatore Sir Francis Drake, corsaro al soldo di sua maestà la Regina Elisabetta I d'Inghilterra, dopo Magellano, primo della perfida Albione a circumnavigare il globo, il viceammiraglio della flotta inglese che nel 1588 sconfisse l'Invincibile Armada – evidentemente non così invincibile – lo stesso che, avvertito dell'arrivo della flotta nemica mentre giocava a bocce a Plymouth, pare abbia detto che c'era tempo sufficiente per finire la partita e sconfiggere gli spagnoli – e infatti fu così – alla fine morì nella baia di Portobello, a 56 anni, di una malinconica dissenteria. Perché forse è questa, in ultima istanza, l'altra faccia della gloria. La vita, anche quella dei grandi e dei migliori, è inevitabilmente un declino: a volte viene da pensare che sia un racconto scritto male.
A me personalmente restano il ricordo del mare che si apre e quello della terra che appare. Il rimpianto dei miei affetti, del mio tempo, forte come la memoria di un dolore. La coscienza delle buone azioni e di quelle efferate. I miei successi e le incapacità. Il riposo dell’oblio nel vasto mare della dimenticanza e l’orgoglio riesumato della memoria. Il sudario della storia che mi avvolge. E allora “addio” Cristóbal, portatore del nome di Cristo, esploratore e navigatore incauto e temerario: a Dio mi affido nell’ultimo viaggio verso il nulla, alla fine del mondo e della vita.
Marco Celati
Pontedera, Settembre 2021
_______________________
Devo a Wikipedia, alle mie poche o tante letture e a qualche insulsa riflessione sulla vita questo scritto. Ringrazio Libero Venturi per aver consentito il saccheggio dei suoi Pensieri della Domenica: “Cristoforo Colombo” e “Magellano”, alla cui lettura rimando gli oziosi e gli indulgenti che leggono anche me.
https://www.quinewsvaldera.it/blog/pensieri-della-domenica/magellano-blog-libero-venturi.htm
Marco Celati